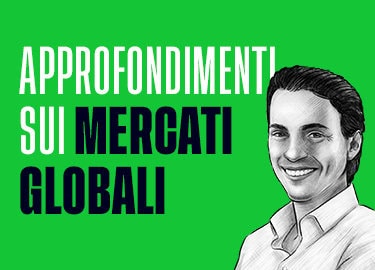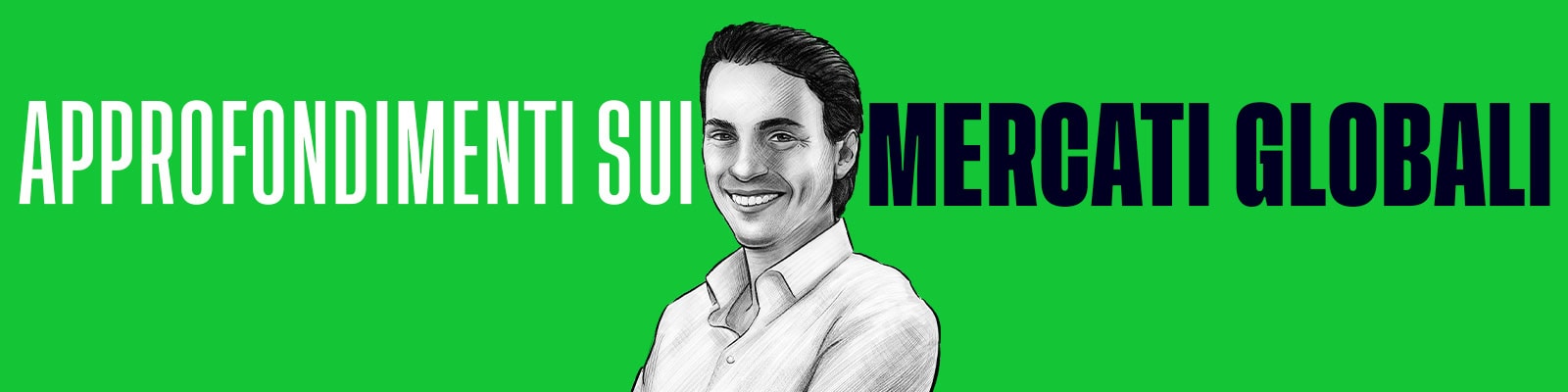Per 33 giorni consecutivi, l’S&P 500 non aveva registrato un movimento giornaliero, in valori assoluti, superiore all’1%. Troppa calma, per troppo tempo. Venerdì l’indice ha perso il 2,71% in una sola seduta, chiudendo la settimana con un calo complessivo del 2,43%, la peggiore dal 19 maggio. Il Nasdaq ha ceduto, sempre venerdì, il 3,49%, il Russell 2000 il 3,01%. Dopo mesi di rialzi verticali e di compiacenza, è bastato un cambio di tono nella narrativa geopolitica per riaccendere l’avversione al rischio.
Il detonatore è arrivato da Pechino. Il 9 ottobre la Cina ha ampliato il regime di controlli all’export su terre rare e materiali strategici. Non una misura tecnica, ma un segnale politico. Le nuove regole impongono licenze per qualsiasi prodotto che contenga più dello 0,1% di terre rare cinesi o sia stato realizzato con apparecchiature che le utilizzano. È una mossa che colpisce il cuore delle catene globali, dai semiconduttori alla difesa, dalle batterie alle rinnovabili. Alcune misure sono già effettive, le restanti entreranno in vigore il 1° dicembre. Contestualmente Pechino ha aggiunto nuove aziende statunitensi alla propria “unreliable entity list”. È una risposta misurata, ma diretta, al nuovo pacchetto di restrizioni americane.
La risposta di Trump è stata immediata. Dazi del 100% su tutti i beni cinesi a partire dal 1° novembre, nuove restrizioni su software e componenti critici e un monito: “una moral disgrace in international trade”. Una classica mossa di Trump, minacce tariffarie eclatanti poco prima di un vertice per guadagnare margine negoziale. I controlli cinesi sulle terre rare rispondono alla stessa logica. Colpi tattici, non un cambio strutturale di strategia.
Eppure, la Cina non arriva a questo confronto da una posizione di debolezza. I dati commerciali di settembre mostrano un’economia ancora resiliente: le esportazioni sono cresciute dell’8,3% su base annua, il ritmo più rapido degli ultimi sei mesi, mentre le importazioni sono aumentate del 7,4%, ben oltre le attese. Il surplus commerciale con gli Stati Uniti è rimasto elevato, oltre 22 miliardi di dollari nel mese e più di 208 miliardi da inizio anno. Una performance che riflette la capacità delle imprese cinesi di riorientare i flussi verso mercati alternativi, compensando l’effetto dei dazi statunitensi. È questo che consente a Pechino di mantenere una postura negoziale più assertiva in vista dell’APEC, forte nei numeri, ma ancora fragile nella fiducia interna.
Ma i mercati questa volta non hanno reagito con distacco. Non perché avessero fiutato la tensione in anticipo, fino a giovedì il VIX restava ancorato a 17, ma perché erano andati troppo oltre. Valutazioni elevate, posizionamenti lunghi e una volatilità compressa da settimane avevano reso le azioni vulnerabili. Bastava una scintilla, e la molla si è distesa di colpo.
Venerdì il VIX è balzato del 32%, chiudendo sopra i 21 punti, il maggior rialzo giornaliero dal mese di aprile. Non un segnale di panico, ma la fine della compiacenza. Dopo 49 sedute consecutive sotto i 20 punti, la volatilità implicita è tornata a prezzo. Il VVIX, la volatilità della volatilità, è risalito a 116. Segnale che la domanda di protezione è tornata, ma senza isteria. Gli operatori stanno pagando per coprirsi, non per fuggire. Più interessante invece è lo SKEW, sceso verso 138. Non è un segno di euforia, ma la conseguenza naturale di un sell-off improvviso. La curva di volatilità si è appiattita non perché gli investitori abbiano smesso di temere il ribasso, ma perché si stanno proteggendo dove serve subito, non in coda.
L’S&P 500 ha chiuso venerdì in calo del 2,7%, il Nasdaq del 3,6%, lo Stoxx 600 europeo dell’1,3%. Le big tech sono state le prime a cedere, con un ribasso del settore (ETF XLK) del 4%. I rendimenti sul Treasury decennale sono scesi di 9 punti base, il petrolio ha perso il 4%, scivolando sotto i 60 dollari, mentre l’oro ha toccato il suo quarantunesimo massimo dell’anno, sopra i 4.000 dollari. Tutti i classici dell’avversione al rischio. Tutti, tranne uno: il dollaro, che invece di rafforzarsi si è indebolito. Un’anomalia, ma non una novità di questo 2025.
Nel frattempo, il mondo crypto ha vissuto il suo collasso tecnico. Bitcoin ha perso il 15% in un’ora, Ethereum il 20%, alcune altcoin la metà del loro valore. È stata la più grande ondata di liquidazioni della storia del settore. Il detonatore è stato lo stesso: le tensioni tra Washington e Pechino. Ma la deflagrazione è arrivata dall’interno. Mercato iper-leveraged, liquidità sottile e vendite automatiche hanno innescato una valanga. Eppure, già domenica Bitcoin era risalito sopra i 115 mila dollari, segno di una resilienza che solo un anno fa sarebbe stata impensabile.

La settimana si è così chiusa con un quadro emotivo ribaltato in poche ore. Domenica Trump scrive: “Don’t worry about China, it will all be fine. President Xi just had a bad moment.” Bastano 17 parole per cambiare il sentiment globale. I future rimbalzano dell’1-2%. La calma, di nuovo. Ma è una calma diversa, più fragile, più tattica, più consapevole.
Dietro il rumore resta la sostanza. Pechino e Washington stanno negoziando con le armi economiche del XXI secolo: chip, terre rare, software. La loro forza non sta più nel commercio, ma nel controllo delle filiere. Entrambe sanno che non possono permettersi un’escalation vera. Ma entrambe vogliono arrivare al vertice APEC in posizione di forza. Ogni post, ogni dazio minacciato, ogni licenza sospesa è un messaggio strategico prima che politico.
Eppure, dietro il braccio di ferro si intravede una tendenza di fondo: gli Stati Uniti non arretrano sulla via dell’autosufficienza industriale. Washington sta costruendo la propria politica industriale sovrana, con capitali diretti su acciaio, semiconduttori e materie prime critiche. Nomi come US Steel, MP Materials, Lithium Americas, Trilogy Metals e Intel diventano tasselli di un nuovo sistema economico di sicurezza nazionale. È il segnale che il tema delle catene corte e dell’indipendenza tecnologica non è più congiunturale, ma strutturale. A breve termine, questa incertezza pesa sui settori più esposti all’export e alla Cina (hardware, auto, logistica) ma nel medio periodo rafforza il vantaggio competitivo delle aziende più domestiche e di qualità. L’America si sta chiudendo per proteggere, non per isolarsi.
Mentre Wall Street e l’Europa tentano oggi di risollevarsi, la Cina arretra ancora: Shanghai -1%, Shenzhen -2,3%. Che sia il riflesso di due narrative opposte? Ovvero di un Occidente che scommette su una distensione negoziale e di una Cina che teme un cambio di paradigma più profondo. E quando i mercati divergono, la volatilità diventa la lingua comune.
La correzione di venerdì non è l’inizio di un crollo, ma la fine dell’indifferenza. La geopolitica è tornata a scrivere la price action. E oggi più che mai i mercati non leggono le notizie, leggono i toni, gli aggettivi, le pause.
Appuntamenti della settimana
Settimana densa di eventi e dati macro, con la narrativa geopolitica che lascia il passo ai fondamentali. Negli Stati Uniti si apre ufficialmente la stagione delle trimestrali del terzo trimestre, che offrirà la prima vera verifica sullo stato dell’economia corporate. JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo, Bank of America e Morgan Stanley apriranno la settimana con focus su margini di interesse, efficienza e gestione dei costi. Gli investitori si attendono indicazioni positive dal comparto investment banking e un possibile rialzo delle guidance di redditività, mentre nel credito retail l’attenzione resta sulla qualità degli attivi. Tra i non finanziari, BlackRock sarà termometro dei flussi verso obbligazioni e fondi passivi, Johnson & Johnson offrirà visibilità sulla pipeline farmaceutica e sul comparto MedTech, Progressive aggiornerà sui costi sinistri e American Express sui volumi di spesa premium e sulla qualità del credito.
Sullo sfondo, lo shutdown federale entra nella terza settimana, ritardando parte delle statistiche ufficiali, tra cui inflazione, vendite al dettaglio e PPI. Restano comunque in calendario produzione industriale, indici manifatturieri di New York e Philadelphia, sondaggi NFIB e NAHB e il Beige Book di giovedì. Lunedì i mercati obbligazionari resteranno chiusi per il Columbus Day.
Sul fronte energetico, l’OPEC pubblicherà il report mensile in un contesto di greggio ai minimi da maggio, mentre a Washington prosegue lo stallo politico sul bilancio. Tra i corporate event, la settimana sarà dominata dall’OCP Global Summit di NVIDIA, dall’Oracle AI World con Larry Ellison e dal Cloudflare Connect, centrati su intelligenza artificiale e infrastrutture cloud. Martedì Jerome Powell parlerà al meeting NABE di Filadelfia, con i mercati pronti a captare ogni segnale di politica monetaria. Sempre in settimana debutterà Dreamforce, la conferenza di Salesforce su cloud e big data con Sundar Pichai e Marc Benioff, mentre Microsoft chiuderà definitivamente il supporto a Windows 10, spingendo un nuovo ciclo di sostituzione hardware.
In Europa, focus sulla produzione industriale dell’Area euro, vista in calo ad agosto dopo il rimbalzo di luglio, e sull’indice ZEW tedesco, atteso in lieve miglioramento a 39,5 punti. Nel Regno Unito i riflettori si spostano sul mercato del lavoro e sul PIL di agosto, stimato in crescita dello 0,2%. Arriveranno anche i dati finali sull’inflazione europea e le bilance commerciali di Italia e Germania.
A livello globale, l’IMF pubblicherà il World Economic Outlook, aggiornando le proiezioni su crescita e inflazione in un contesto di tassi ancora restrittivi e frammentazione geopolitica crescente.